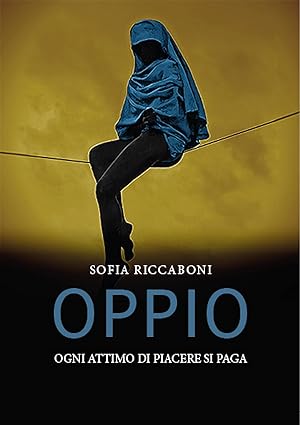“Giovanni Paolo II è stato un costruttore di ponti tra contraddizioni”. “Non abbiate paura” può suonare ancora più forte di quanto non fosse nel 1978.
Da una prospettiva odierna, questo invito “Non abbiate paura” può suonare ancora più forte di quanto non fosse nel 1978. Oggi abbiamo più paure: non abbiamo più paura solo della persecuzione politica, della mancanza di stato di diritto, della perdita del lavoro, della malattia, della povertà, ma abbiamo anche nuove fonti di ansia: la crisi ecologica, i social media, la polarizzazione politica. Ma alla fine, ciò che più ci spaventa è noi stessi, ciò che troveremo nel caos delle nostre teste, delle nostre famiglie, delle nostre comunità – afferma il Prof. Michał Łuczewski in un’intervista a tvp.info sul pontificato di Giovanni Paolo II.
Come è stato il pontificato di Giovanni Paolo II ? Quale possiamo considerare la questione più importante in questo caso?
Possiamo menzionare subito alcuni di questi temi più importanti, ma non basteranno a catturare l’essenza dell’unicità di Giovanni Paolo II . Noi diciamo: Ha rovesciato il comunismo, ha apprezzato il ruolo delle donne, ha difeso i diritti umani, ha compiuto importanti gesti ecumenici, ha compiuto pellegrinaggi in tutto il mondo e ne ha cambiato il volto, ci ha donato il nuovo Catechismo della Chiesa Cattolica, migliaia di santi e la Solidarietà…
Ma…
Ma la cosa più importante nel pontificato di Giovanni Paolo II è sempre stato l’uomo. In tutti questi grandi gesti, si parlava di una persona: una persona specifica che affrontava le sue sfide, ma alla fine, proprio alla fine, si parlava di una persona specifica: Karol Wojtyła, un uomo dell’intellighenzia polacca di Wadowice. Perché il Papa dovrebbe guadagnare il mondo intero e perdere la sua anima? A volte pensiamo che i papi siano stati creati per noi, che i loro pellegrinaggi siano pellegrinaggi verso di noi, ma il papa deve preoccuparsi prima di tutto della salvezza della sua anima e del suo pellegrinaggio verso Dio. Nel pontificato di Giovanni Paolo II la persona più importante è stata Karol Wojtyła, nel pontificato di Benedetto XVI Joseph Ratzinger e nel pontificato di Francesco Jorge Mario Bergoglio. Lo capivamo bene, perché per noi Karol Wojtyła era una persona in carne e ossa, che a volte potevamo conoscere meglio attraverso i suoi gesti, i suoi scritti, la sua poesia, rispetto ai nostri cari.
Come è iniziato questo pontificato? Questo primo punto importante era forse il suo anticomunismo dichiarato? La lotta contro questo sistema di cui hai già parlato?
L’anticomunismo è stato molto importante, ma non riduciamo Giovanni Paolo II a uno dei supereroi della Guerra Fredda, insieme a Ronald Reagan e Margaret Thatcher, che sconfissero l’impero del male. La lotta contro il comunismo era solo un aspetto del progetto positivo del papa di trasformare il mondo. Giovanni Paolo II ha compreso profondamente le tensioni dei tempi contemporanei e vi è entrato per dare loro senso, direzione e coerenza. Secondo lui, il comunismo rappresentava un approccio materialista all’uomo, riducendolo al ruolo di un essere economico privo di anima. Questo fu l’“errore antropologico” fondamentale del comunismo che portò alla sua caduta. Ciò che a volte dimentichiamo è che Wojtyła era anche un critico del materialismo occidentale, che era e si basa sullo stesso errore. Ricordiamo il suo primo pellegrinaggio in Polonia nel 1979, ma non ricordiamo che nello stesso anno visitò gli Stati Uniti, dove, contrariamente ai suoi amici, espresse osservazioni critiche sul capitalismo. Entrambi i sistemi – comunismo e capitalismo – hanno ridotto l’uomo a una dimensione puramente materiale. Il Papa ha visto la necessità di una trasformazione spirituale basata sulla cura dell’anima e della dignità della persona umana. Nella sua visione, la “Solidarnosc” polacca era una risposta a entrambi i materialismi: quello comunista e quello capitalista. Per me, questo era il “socialismo dal volto divino”, che evitava le ombre di entrambi i sistemi, pur affrontando le vere questioni a cui entrambi i sistemi erano risposte. Le nostre vite non dovrebbero essere collettivizzate, come temevano i sostenitori del libero mercato, guardando al comunismo, ma non dovrebbero nemmeno essere individualizzate, narcisistiche e instabili, come temevano i fondatori del socialismo, guardando alle società occidentali. Giovanni Paolo II era un personalista e voleva stare tra questi estremi. Un sistema politico adeguato dovrebbe proteggere sia la comunità che l’individuo.
Si potrebbe dire che ha trasformato il concetto di “solidarietà”, di cui anche i comunisti si servivano in una certa misura, in uno slogan più, diciamo, sottile e prezioso?
È bene che ne parliamo. Il concetto stesso di “solidarietà” è un concetto che ha origine dalla Rivoluzione francese, introdotto da Pierre Leroux, che voleva sostituire “solidarietà” con la caritas cristiana, l’amore. Il concetto di “amore” gli sembrava troppo passivo, privo di dinamiche rivoluzionarie, ineguale e, a suo avviso, serviva alla Chiesa per oscurare i rapporti di potere nella società feudale. A causa della sua origine rivoluzionaria, il concetto di “solidarietà” fu in seguito utilizzato dai movimenti socialisti di sinistra, da cui attinsero i comunisti. I lettori più anziani ricorderanno che negli anni ’70 veniva utilizzato nel contesto della solidarietà con nazioni fraterne, ad esempio nel 1965 venne fondato il Comitato Polacco di Solidarietà con le Nazioni dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Nello stesso periodo, Karol Wojtyła stava elaborando il suo concetto di solidarietà, che apparve come fondamentale nel contesto degli atteggiamenti autentici in “Persona e atto” (1969) e nel Concilio Vaticano II (“Sulle basi del rinnovamento”; 1972). La sinistra voleva sostituire l’amore cattolico con la solidarietà rivoluzionaria, e Wojtyła stava facendo sì che la solidarietà rivoluzionaria tornasse ad essere amore cattolico. Ricordando lo sciopero nel cantiere navale di Danzica, vedremo che le icone di “Solidarność” non erano Marx, ma Giovanni Paolo II, la Madonna di Częstochowa e Gesù Misericordioso. Grazie a ciò, “Solidarnosc” assunse improvvisamente un volto divino e non solo umano. Questa fu la misura del successo di Karol Wojtyła. Ciò dimostra la strategia di Wojtyła, che non era quella di rifiutare la solidarietà perché proveniva da un vocabolario ostile, ma di farla propria, elevarla, raffinarla e nobilitarla.
Nel contesto di Giovanni Paolo II, si dice spesso che egli è stato uno dei pochi pensatori contemporanei ad aver pensato in grande, e non solo nel presente. Saresti d’accordo?
In questo contesto, pensiamo non solo ai pensatori, ma anche a noi stessi. Ognuno di noi deve superare la giornata: corriamo, inseguiamo, cerchiamo di soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Nel sistema in cui viviamo oggi è facile minare la nostra forza e dignità. Oggi basiamo spesso il nostro valore sul prestigio, sui guadagni e sulla posizione. Ma tutto questo può essere facilmente perso a causa di malattie, drammi della vita, cali del mercato azionario. Quindi, come possiamo costruire una dignità che nessuno potrà mai toglierci?
Wojtyla aveva una risposta a questa domanda. E lui doveva sopravvivere, proprio come noi, ogni giorno. Ma lo ha fatto in uno stile diverso! Wojtyła non poteva essere privato della sua dignità durante il periodo comunista, e non gliela toglieremo nemmeno ora, anche se dopo la sua morte viene criticato. In precedenza, quando era in vita, i polacchi lo idolatravano – a volte idolatravamo noi stessi perché lo idolatravamo così tanto, e idolatravamo lui per idolatrare ancora di più noi stessi, ma spesso non capivamo che invece di ammirare Wojtyła, era meglio imitarlo e cercare fonti di forza per noi stessi dove le trovava lui.
Era profondamente radicato nel suo popolo, e questo era importante. Per lui era importante essere polacco. Per lui la polandità era allo stesso tempo normalità e – per così dire – una realtà metafisica e soprannaturale, perché gli permetteva di dialogare con i grandi spiriti defunti, ma per lui ancora vivi, della cultura, della storia e della politica polacca, con i “re fantasma” della nazione polacca, come lui stesso diceva citando Juliusz Słowacki. Poteva parlare con poeti, santi, pensatori, etmani, re.
La seconda dimensione importante della sua identità era lo slavismo. Rappresentava quella parte del mondo schiavizzata dal comunismo e non lo rinnegò mai. Solo grazie a lui gli slavi poterono finalmente parlare con la propria voce, senza traduttori occidentali. Wojtyła, sostenuto dal messaggio profetico di Fatima (1917), credeva che la Russia potesse convertirsi. Pensate un po’: chi ha oggi un simile senso della missione?
E la terza fonte della dignità di Wojtyła è la Chiesa. Wojtyła non era quindi solo un esponente dell’intellighenzia polacca, ma anche il capo della Chiesa, che concepiva la propria missione in una prospettiva mondiale. Chi di noi pensa in termini di migliaia di anni? In primo luogo, insieme al primate Wyszyński, ha commemorato il millennio del battesimo polacco e, dopo la sua elezione a papa, il primate Wyszyński gli ha detto: “Tu guiderai la Chiesa nel nuovo millennio”. Wojtyła si considerava un seguace di Abramo, di Mosè, una guida al confine delle epoche.
Dietro Wojtyła c’erano quindi la Chiesa, gli slavi e la nazione polacca. Chi c’è dietro di noi? Per i nostri politici al potere? Vedo il vuoto lì. Ecco da dove nasce la polarizzazione, perché costruiamo il nostro valore sul risentimento, a spese dell’altra parte, e non costruendo la nostra dignità.

Giovanni Paolo II (foto: Getty Images)
Wojtyła ha dimostrato quanto sia importante una prospettiva sia globale che locale.
Assolutamente sì. Ciò si può osservare, ad esempio, nel Trittico romano , dove da un lato abbiamo una prospettiva storica, cosmica, che risale al Libro della Genesi, alla Parola che era all’inizio, ai tempi dei patriarchi, e dall’altro una prospettiva universale, nella contemplazione della Cappella Sistina. Per rappresentare la creazione dell’uomo, Michelangelo dipinse il tetto sopra le teste dei papi, realizzando il suo più grande capolavoro. Ma accanto a questa visione ampia, esiste anche una dimensione profondamente umana, locale, piena di tenerezza e di radicamento. Il trittico inizia con le parole: “La baia della foresta scende al ritmo dei ruscelli di montagna” – questo è un riferimento alla gola del Wisłok, un luogo a lui ben noto, dove trascorse del tempo con Wanda Półtawska durante il “ritiro sui Beschidi”. La poesia di Wojtyła è l’essenza della sua persona. Nel Trittico, come in tutto il suo pontificato, si incontrano la storia della cultura umana, le più belle opere dell’uomo e, allo stesso tempo, il desiderio della natura, quella polacca, di cui tanto sentiva la mancanza. Per questo motivo le dedicò la sua ultima poesia.
In una delle sue interviste ha affermato che Giovanni Paolo II era “un aiutante, un amico dell’economia”. Cosa significa esattamente? Dopotutto, non era un sostenitore del capitalismo.
Egli era, prima di tutto, un collaboratore della Verità e un amico del “nostro Dio”, che era suo Amico. Per lui la cosa più importante era la cosiddetta economia di Dio. Non si trattava del sistema economico, ma del mistero dell’Incarnazione: l’avventura di Dio e dell’uomo. Perché Dio è entrato nella storia umana? È da questa prospettiva che il Papa guarda il mondo: come messaggero di Dio, profeta, sacerdote e re – perché ogni cristiano, come ha spesso sottolineato, ha una triplice dignità. Egli venne come rappresentante di un altro mondo, quello “blu”, e vide il nostro mondo terreno senza illusioni. Così come voleva dare un volto divino al socialismo, così voleva darlo anche al capitalismo. Oggi può sembrare ancora più rischioso, perché il comunismo è caduto e il capitalismo resiste e resisterà fino alla fine del mondo e ancora per un giorno. Wojtyła sostenne la libera impresa e criticò le distorsioni del capitalismo: la disumanizzazione, la subordinazione dell’uomo al profitto, la subordinazione del lavoro al capitale. Allo stesso tempo, vedeva il valore della libertà e della creatività: l’economia dovrebbe essere un’espressione dello spirito umano, non la sua schiavitù. Per realizzare i nostri obiettivi dovremmo iniziare da noi stessi, non trattandoci come un mezzo per raggiungere un fine, ma come un fine. Possiamo adattare molto facilmente i nostri valori ai nostri interessi, ma Wojtyła si chiedeva costantemente se i nostri interessi dipendessero da noi.
Come dobbiamo intendere le sue celebri parole: “Non abbiate paura”?
Da una prospettiva odierna, questa chiamata potrebbe suonare ancora più forte di quanto non lo fosse nel 1978. Oggi abbiamo più paure: non temiamo più solo la persecuzione politica, la mancanza di stato di diritto, la perdita del lavoro, la malattia, la povertà, ma abbiamo anche nuove fonti di ansia: la crisi ecologica, i social media, la polarizzazione politica. Ma alla fine, ciò che più ci spaventa è noi stessi, ciò che troveremo nel caos delle nostre teste, delle nostre famiglie, delle nostre comunità. Oggi tutto sta crollando e stiamo perdendo i nostri punti di riferimento. Un tempo si sapeva che il comunismo era cattivo e Solidarnosc era buono, oggi non abbiamo paura dei dittatori, ma dei nostri simpatici amici di Facebook che possono voltarci le spalle in qualsiasi momento e cancellarci, abbiamo paura della persecuzione nascosta, “educata”, come ha descritto Papa Francesco la sorridente esclusione dei cristiani che ci è propria, non abbiamo paura di combattere gli autocrati, ma i democratici con il machete, persone che predicano idee libertarie per limitare la libertà. Sempre più spesso dobbiamo rispondere alla domanda chi è il nemico e chi è l’amico.
Sebbene le parole da lei pronunciate siano diventate il simbolo di tutto il suo pontificato, l’invito di Dio a non avere paura è una sorta di ritornello presente nella Bibbia, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. Questa chiamata significa che non siamo e non dobbiamo essere la nostra paura. Abbiamo un’anima, abbiamo quel “di più” che la paura non può distruggere. Se smettiamo di identificarci con la nostra paura, possiamo sentirci liberi e allora è possibile fare un passo nella direzione di cui prima avevamo paura. Perché molte delle nostre scelte – carriere, relazioni – si basano sulla paura. È importante che non compiamo questo passo da soli, ma che sia Dio a guidarci. Ecco perché Giovanni Paolo II ha detto: “Non abbiate paura, aprite, spalancate le porte a Cristo. Per la sua potenza salvifica, aprite i confini degli stati, i sistemi economici e politici, le vaste aree della cultura, della civiltà, dello sviluppo! Non abbiate paura! Cristo sa cosa l’uomo porta dentro di sé. Lui solo lo sa!”
Si dice spesso che Giovanni Paolo II fosse un uomo “integrale”. Cosa significa esattamente?
Questa è una delle sue parole preferite. Seguendo Papa Paolo VI, scrisse dello sviluppo integrale, cioè del pieno sviluppo dell’uomo e di ogni persona. Allo stesso tempo, l’integrità umana è la realtà che nessuno e niente può toglierci la dignità. Quando guardiamo a Karol Wojtyła, vediamo un uomo integro: qualcuno che ha sviluppato tutta la sua umanità, che ci ha resi più umani e che non ha mai perso la sua anima. Chiamiamo queste persone santi.
Quale era l’approccio di Giovanni Paolo II alla democrazia?
Penso che Wojtyła sia stato l’ultimo rappresentante della nobile democrazia! In una tale democrazia il re è solo primus interest pares . Wojtyła democratizzò l’aristocratico “repubblicanesimo dello Spirito” di Słowacki; il suo messianismo non si limitò a individui eccezionali, ma fu un messianismo per le masse. Ognuno di noi può imitare il Messia e scoprire dentro di sé la dignità messianica del Figlio di Dio. La prima messa di Wojtyła ebbe luogo nella cappella di San Leonardo a Wawel, tra i cosiddetti “re fantasma”. Sono sepolti Tadeusz Kościuszko, p. Józef Poniatowski e Jan III Sobieski. Questo era l’egualitarismo di Wojtyła: in Polonia tutti possono diventare uguali ai re e riposare accanto a loro, come i suoi padroni, Juliusz Słowacki e Adam Mickiewicz.
Giovanni Paolo II ha cambiato la percezione del comunismo non solo in Vaticano, ma in tutto l’Occidente?
Dobbiamo chiederci quale fosse la percezione del comunismo a quel tempo? La Chiesa ha avuto la tendenza, come oggi con Papa Francesco, a perseguire la Realpolitik. Wojtyla ruppe con questa impostazione. Contrariamente ai realpolitikisti irrealistici, egli cambiò la percezione del comunismo in una più realistica, ma allo stesso tempo dimostrò che questo sistema non ha l’ultima parola. Lo vedeva come un sistema malvagio in cui era presente il mistero dell’iniquità, ma l’ultima parola spettava a Solidarietà! Wojtyła, come papa, non giocò al gioco di questo mondo con i potenti, ma li sfidò. E non si trattava solo di Brežnev o Gorbaciov. Ma anche molto più tardi, ad esempio su George W. Bush. Quando tutti sostenevano la guerra in Iraq, Giovanni Paolo II era contrario. E aveva ragione.
Possiamo dire che Giovanni Paolo II non si è lasciato forzare in alcun modo?
Wojtyła era un pontifex, cioè un costruttore di ponti tra contraddizioni. Ecco perché è così difficile incasellarlo. Per alcuni era troppo progressista, per altri troppo tradizionale. Troppo morale per i liberali, troppo aperto per i conservatori. Il Papa ha collegato l’Oriente con l’Occidente, l’anima con il corpo, la donna con l’uomo, la fede con la ragione, la memoria con l’identità, il dono con il mistero, la persona con l’azione. Non si è trattato solo di una sintesi intellettuale: è stato un viaggio spirituale. Eppure è difficile integrare queste contraddizioni incredibilmente vivificanti. A volte addirittura impossibile. Wojtyła sapeva che qui non è possibile una piena integrazione e che solo in cielo potremo liberarci da tutti gli schemi.
In una delle tue interviste hai detto: “Quando Giovanni Paolo II incontrava qualcuno, quella persona aveva l’impressione che stesse guardando nella sua anima. E quando incontriamo qualcuno, sappiamo in anticipo cosa dirà l’altra parte e non ascoltiamo nemmeno”. Si tratta davvero di noi?
Robert Korzeniowski, il nostro marciatore più decorato, ha regalato al Papa la sua… scarpa con cui è andato a vincere l’oro olimpico. Guardando questo dono, Giovanni Paolo II avrebbe potuto vedere delle scarpe sudate o un atleta senza misura, ma – ne sono convinto – ha capito che quella scarpa contiene tutto il cuore dell’atleta, che è la cosa più preziosa che egli possa donare. Wojtyła sapeva guardare oltre la superficie, fino al cuore. I polacchi si sono presentati a Wojtyła con le loro “scarpe”, ma lui ha visto il nostro cuore. E il cuore è una metafora dell’anima, è un’icona di fede, speranza e amore, cioè non rimanda a se stesso, ma a Dio. Stanisław Grygiel diceva che Wojtyła si inginocchiava davanti a ogni persona. Chi di noi oggi si inginocchia davanti a qualcuno? Preferiremmo che fossero gli altri a inginocchiarsi davanti a noi oppure che fossimo noi a inginocchiarci davanti a noi stessi. E perché Wojtyla si inginocchiò? Perché sapeva che nel nostro cuore, nella nostra anima, c’è un tabernacolo dove Dio è nascosto.
***
Michał Łuczewski: prof. UW, sociologo, psicologo, metodologo, vicepresidente della Fondazione Polska Wielki Projekt, direttore di programma di lunga data del Centro di pensiero Giovanni Paolo II.